Gli Yogasutra sono una collezione di 196 aforismi, suddivisi in quattro sezioni, attribuiti dalla tradizione al saggio Patanjali.
Chi è Patanjali?
Le divergenti opinioni, per esempio, sulla datazione del testo, oppure su chi sia in realtà Patanjali, se sia realmente esistito oppure sia una figura mitologica; o anche i pareri diversi sulle quattro sezioni del testo non sono poi così essenziali e non inficiano minimamente la sua validità e importanza come libro spirituale, che può essere utilizzato come guida per la pratica individuale. Da quando gli inglesi hanno invaso l’India, si è avuta un’incredibile produzione di traduzioni, studi filosofici e filologici, nonché commentari di carattere più spirituale, che testimoniano la vitalità di questo testo.
Il termine sutra, in generale tradotto con aforisma, significa letteralmente filo:
tradizionalmente si usa l’immagine del filo che unisce le perle di una collana.

Come forma letteraria, ha la caratteristica di essere molto sintetico, scarno, e di contenere solo i principi essenziali, “le perle” appunto dell’insegnamento. Se consideriamo che la cultura indiana era prevalentemente orale, e che l’insegnamento era trasmesso nel rapporto diretto, vivo, tra insegnante e allievo, allora la sinteticità del testo favoriva la memorizzazione e la recitazione. Poiché il testo in sé è di difficile se non impossibile comprensione, era l’insegnante che forniva le chiavi interpretative all’allievo: esse erano commisurate alle capacità e all’esperienza dello stesso, così da consentire lo sviluppo organico e fluido della sua comprensione.
La sua forza ed efficacia stanno proprio nell’intrinseca ambiguità e quindi nella ricchezza di significati che gli si può attribuire, nella sua capacità di canalizzare un insieme di contenuti che mantengono però organicità e coerenza.
Raffaele Torella, eminente studioso italiano, si esprime in questo modo:
Il sutra era espressamente investito del ruolo insostituibile di segno della continuità di una tradizione, ruolo che proprio la sua forma di testo “embrionale” rende possibile. In virtù della ricchezza inesauribile di significato che gli viene attribuita, esso può costituire sia il punto di partenza che quello di arrivo; uno dei requisiti caratteristici del sutra è appunto quello di essere polisemico. L’ambiguità di cui in tal modo il sutra si carica non è vista come un difetto, ma al contrario come un requisito essenziale perché il sutra sia tale. A fornire il materiale di base per tale programmatica ambiguità ci pensa la lingua sanscrita, con la sua naturale polisemia.
hatha yoga anushasanam (YS I.1)
ECCO L’INSEGNAMENTO DELLO YOGA
yogash chitta vritti nirodhah (YS I.2)
YOGA ACCADE QUANDO L’ATTIVITÀ RIPETITIVA, REATTIVA DELLA MENTE SI ACQUIETA
tada drashtuh svarupe avasthanam (YS I.3)
ALLORA CIÒ-CHE-VEDE DIMORA NELLA SUA PROPRIA FORMA
vritti sarupyam itaratra (YS I.4)
ALTRIMENTI CIÒ-CHE-VEDE È IDENTIFICATO NELL’ATTIVITÀ DELLA MENTE
Anche se il secondo aforisma (yogash chitta vritti nirodhah) è quello più citato in assoluto, se iniziamo la nostra riflessione dal quarto aforisma (vritti sarupyam itaratra), forse il tutto può diventare più chiaro.
Esso descrive il nostro stato abituale di con-fusione e di agitazione mentale in cui ci identifichiamo, ci perdiamo, ci appropriamo dei pensieri, delle emozioni e delle percezioni sensoriali che, di momento in momento, sono presenti nello spazio della consapevolezza.
Chiunque abbia provato anche solo qualche volta a sedere in silenzio, in meditazione, ha constatato quanto è facile essere catturato dai pensieri e quindi distrarsi, dis-perdersi.
Il terzo aforisma (tada drashtuh svarupe avasthanam) ci dice che, nello stato di yoga, ciò-che-vede (drashtuh), cioè la consapevolezza, la facoltà di percepire conoscere, la presenza istantanea, la coscienza, chiamatelo come volete, rimane nella sua naturale chiarezza e spaziosità, senza offuscamenti, senza interferenze.
Noi perdiamo coscienza non solo quando “fisicamente” perdiamo i sensi, ma perdiamo coscienza anche ogni volta che “mentalmente” ci appropriamo di ciò che non siamo, di ciò che non è nostro, cioè ci identifichiamo con pensieri, emozioni e percezioni sensoriali.
Il problema quindi non è l’attività, il movimento (vritti) della mente che si manifesta attraverso pensieri emozioni, ma l’abitudine, il condizionamento mentale a identificarci, ad appropriarci di, a perderci in ciò che è percepito-conosciuto.
Detto in altri termini, il problema non è l’attività mentale in sé (vritti), ma l’incapacità di differenziare, di discernere l’attività mentale dalla coscienza che ne è alla base, incapacità che porta a perdere la presenza e la spaziosità-libertà interiore.
Nello stato di yoga, la consapevolezza, pur continuando a fare il proprio “lavoro”, cioè percepire-conoscere, rimane libera e anzi funziona ancora meglio, con maggiore chiarezza, proprio perché rimane vividamente presente e libera.
Nello Yoga, questo stato di presenza, chiarezza, libertà, non separazione, non dispersione, si manifesta, accade, quando cessa (nel senso di acquietarsi, di tranquillizzarsi) il movimento automatico, ripetitivo, reattivo della mente.
Semplificando un pochino, possiamo considerare due parametri: il numero e l’intensità di pensieri-emozioni da una parte, e la forza dell’identificazione agli stessi dall’altra. Allora possiamo dire che la pratica sinergica e unitaria di posizioni (asana), tecniche di espansione dell’energia vitale (pranayama) e meditazione (dhyana) conduce naturalmente a una diminuzione in termini di numero e intensità di pensieri emozioni e, parallelamente, si riduce il grado di identificazione con gli stessi. I pensieri e le emozioni possono continuare a sorgere ma non ci disturbano più, o ci disturbano di meno, e siamo in grado di dimorare in una condizione di consapevolezza spaziosa, di presenza silenziosa con più continuità e naturalezza.


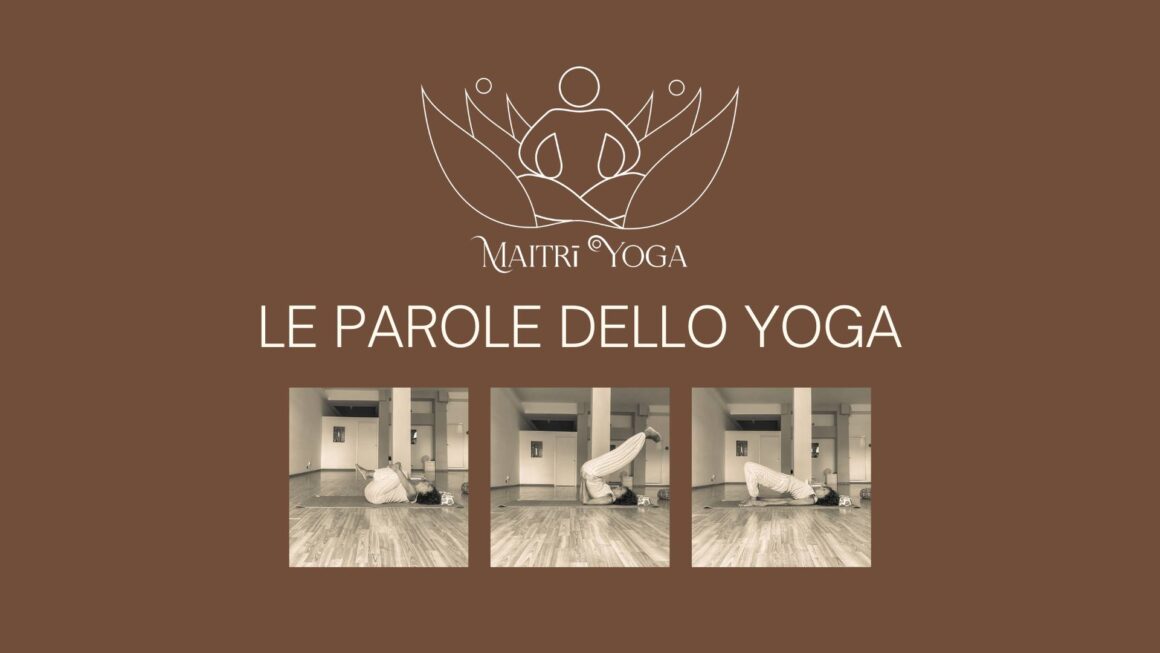
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.